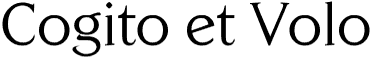Nel riflesso del tempo

Il tempo trascorre anche sul corpo e ne porta i significati. Amarsi a volte è osservare su di sé i solchi dell’esperienza.
Ventitré e trenta nel camerino di un grande teatro di città. Da fuori giunge un brusio allegro: è il momento in cui gli spettatori, chiuso il sipario, si impossessano di ciò che gli è stato offerto dal palco. Opinioni a caldo, chiavi di lettura, commenti alle aggiunte del regista: se anche è vero che la pièce si compie nel qui e ora dello spettacolo, è sempre chi guarda a crearne dopo i significati, a dare un nome agli infiniti volti che porta un attore. O un’attrice.
Lei è in piedi nel camerino, ha ancora addosso il costume di scena. Si sente sicura di sé in quell’abito un po’ datato: lo ha saputo portare con maestria anche stavolta. Lei è la stella che trascina i volti noti in prima fila e con il taccuino in mano, lei è quel nome sempre presente nella locandina della prima della stagione. Lei è la Grande Attrice, un po’ Eleonora Duse, un po’ Adelaide Ristori. E anche stasera è entrata nei panni di un’eroina tragica. Si guarda al grande specchio a parete di fronte a lei: indossa fieramente i suoi sessantacinque anni e porta l’esperienza sui solchi del viso scavato. Ha recitato un’infinità di parti e la maggior parte sono ancora fisse nella sua mente. C’è una strana correlazione, un inspiegabile filo rosso che ha sempre collegato le sue eroine alle sue esperienze di vita, una sorta di riconoscimento di sé nei suoi personaggi. Forse è per questo che si è sempre descritta nelle metafore dei suoi ruoli, anche quando doveva parlare di sé, o a sé. Alla fine di ogni spettacolo si ferma lì, davanti allo specchio, e osserva quella regina, quella maga, quella semplice donnicciola di campagna che ha interpretato e finalmente si appropria nuovamente di sé. Lei è quei personaggi, senza di essi non riesce ad afferrare la sua identità. Lo specchio lo sa, e ogni volta le concede di riprendersi un pezzetto di sé, lasciandola guardarsi, lasciandola raccontarsi.
Da giovane era stata un’acerba Mirandolina, una sfrontata locandiera alle prese con uomini tronfi e gonfi di potere. Erano i suoi primi anni sui grandi palchi e le attenzioni maschili erano una tentazione pericolosa. A guardarla con occhi affamati erano stati vari Cavalieri di Ripafratta e altrettanti Marchesi di Forlipopoli, tutti di certo grandi estimatori della sua arte, cui si permettevano di aggiungere un volutamente non velato apprezzamento per i suoi altri talenti ben più evidenti, a cui più direttamente, più carnalmente puntavano. “Posso renderti qualcuno” le promettevano, era tutto sommato un patto più che equo, non lo era? Ma lei si era liberata ogni volta di quell’immagine di
locandiera seducente, pagando il prezzo fatale dell’aver ferito l’orgoglio di un uomo con un nome. E con i suoi appellativi di frigida e suora, si era specchiata compiaciuta nel suo camerino, sapendo che avrebbe redarguito bamboccioni arricchiti per tutta la vita.
Cresciuta velocemente in quel mare di squali, si era tuttavia con il tempo convinta che anche le donne forti hanno il diritto di essere amate. Ma il destino le era stato poco amichevole. Storie turbolente, amori tragici e passionali, cocenti delusioni avevano dipinto la sua carriera di fattacci e articoli scandalistici. Era stata una Saffo disperata quando, nel suo unico momento di debolezza, si era invaghita di un emergente e aitante giovane attore, e si era illusa che lui la potesse salvare dallo sfiorire degli anni passati. Ma quel Faone l’aveva portata in paradiso per il tempo di una sbornia e l’aveva lasciata a gestirsi i postumi una volta risvegliata. I giornali avevano ipotizzato un naturale affievolirsi della passione di lui, forse era fisiologico che un uomo nel fiore della prestanza desiderasse una rosa appena sbocciata. Quella sera aveva recitato l’infelice Saffo e si era buttata dalle scogliere del suo palazzo per l’amore non ricambiato di Faone. Donna e poetessa, donna e artista, era davvero conciliabile? Nel suo camerino spoglio si era osservata a lungo, aveva ancora il viso stravolto delle ultime parole recitate. Lasciò andare un fiume di emozioni piuttosto umano, che di poetessa divina aveva ben poco. Ma fu solo il bagliore di un istante: non appena si era tolta il costume di scena il volto portava di nuovo la serenità dell’accettazione.
A volte si era dovuta specchiare in immagini che non le appartenevano minimamente. Una volta era stata Nora di “Casa di bambola” e in scena aveva abbandonato il marito e i figli per liberarsi di un ruolo sociale che la ingabbiava. Lei che aveva escluso tempi or sono il matrimonio, lei che aveva accantonato il desiderio di essere madre in diverse occasioni, era ora la moglie ribelle di un dramma borghese. Non si era mai pentita della sua scelta e non lo aveva inteso come un sacrificio. Per certi sogni i compromessi non sono neanche poi così accattivanti, e va bene così. Dopo la messinscena aveva visto nello specchio del camerino un corpo maturo e sicuro di sé, avvolto dalle contraddizioni
di un costume da donna borghese. Quell’abito le donava e si scoprì particolarmente compiaciuta di ammirarsi nel proprio riflesso. Chissà se Nora non torna a casa un giorno, chissà se non le mancano le battute e i soprannomi zuccherosi del marito. Ah, queste gabbie! Che dolce sapore di normalità hanno. Ma anche qui aveva abbandonato presto il sapore del momento e si era rivestita, scrollandosi di dosso quell’amaro sapore del dubbio.
La più dolorosa delle esperienze la portava ancora con sé da decenni. Una delle sue prime parti, peraltro un ruolo, se non minore, quantomeno secondario: era stata la signora Ponza di “Così è (se vi pare)” di Pirandello, ossia una moglie e una figlia sbatacchiata dalle dicerie dei suoi congiunti, priva di un’identità eppure sempre definita dalle parole altrui. Era comparsa nell’ultimissima scena, con il capo coperto da un velo scuro, impenetrabile, e aveva sentenziato che “io sono colei che mi si crede”, nient’altro di diverso. Quelle poche battute l’avevano segnata a vita. Qualsiasi immagine si prefiggesse di portare sarebbe poi stata storpiata dall’unico pubblico che non sapeva gestire, il mondo. Si sentiva destinata a riscoprirsi ogni giorno nell’immagine che avrebbe visto di sé sui giornali, fosse essa femme fatale, zitella sfiorita, nel migliore dei casi irraggiungibile musa del teatro. Le restava solo un’occasione, un unico istante in cui sceglieva lei la propria maschera: erano quei momenti nel camerino, appena finito lo spettacolo, in cui ancora nel costume di scena si poteva riconoscere allo specchio, dando al suo corpo la forma dell’amante sconfitta, della ribelle coraggiosa, della scalatrice sociale.
Ventitré e trentadue nel camerino di un grande teatro di città. Ronza sempre più flebile il brusio del pubblico, ora le conversazioni si sposteranno fuori dall’edificio.
E alla fine cosa rimane? Un attore e il suo corpo, rivestito di una parte che per mesi lo ha definito e di cui ora si deve spogliare.
Come ogni sera lei vorrebbe ammirarsi un po’ allo specchio e rivedersi nella figura che ha portato in scena. L’abito è bello, e lo porta indubbiamente bene, ma stavolta prova sentimenti contrastanti. Non riesce a riconoscersi nella parte che vede allo specchio. Eppure, l’ha recitata così bene! Qualcuno le ha persino lanciato una rosa dagli spalti. Pensa e si ricorda di quando era stata una pericolosa Mirandolina, una straziata Saffo, una risoluta Nora, una lacerata Signora Ponza. E come una doccia
fredda la pervade la consapevolezza che in quei ruoli lei si era riconosciuta solo perché ciò le concedeva di staccarsi dal sé, da quella unicità impossibile da rinchiudere anche nel più complesso dei personaggi. Era fuggita a un’identificazione dell’io nel proprio corpo e si era abbandonata alle sembianze di fanciulle greche o di donne dell’alta borghesia, sperando di potersi riconoscere e – perché no? – di potersi amare nell’immagine universale dell’arte, che sebbene limitante la proteggeva
dalla pubblica esposizione.
E allora si spoglia, si toglie quel costume che la veste come un guanto e si trova finalmente nuda allo specchio. Davanti a sé un corpo sessantacinquenne, snello e a tratti cadente. La pelle porta i segni del tempo e i graffi del dolore, il colore dei successi e l’inconfondibile aspetto della forza. Alla fine, cosa rimane? Un attore e il suo corpo, finalmente spoglio. Una donna e la sua immagine, libera delle parti e delle definizioni. Uno specchio e la grande bellezza del vero, che senza abiti, fronzoli e maschere è ancora una volta la più pura, la più magnifica delle arti.
Foto di Copertina: Ýlona María Rybka (Unsplash)