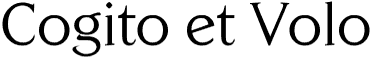Beyond the lyrics: Losing my religion – R.E.M.

«Non si dovrebbe pensare di “perdere” qualcosa. Se lo si pensa, lo si è perso già» – Daniel Glattauer
Questo pezzo appartiene a uno speciale Beyond the lyrics sui brani internazionali che hanno segnato gli anni ’90: gli altri articoli sono reperibili a questo link.
Perdere l’amore, quando si fa R.E.M.
Losing my religion inaugurò con il suo velo di lucida amarezza gli anni ’90 del pubblico americano e non solo. Il titolo è un idioma con varia valenza: niente a che fare con la religione, si può tradurre come perdere la pazienza o perdere la fiducia. Entrambi i significati si adattano bene al brano, che analizza chirurgicamente il processo di disillusione da un amore tossico perché unilaterale.
L’album

Out Of Time (1991, Warner Bros. Records) consacra ufficialmente i R.E.M. all’olimpo della scena underground internazionale con 18 milioni di copie vendute. Una band nata da una conversazione in un negozio di dischi e che in undici anni di attività era giunta al settimo album in studio.
Il singolo Losing my religion spinge così tanto l’album che nello stesso anno viene pubblicata la raccolta The best of R.E.M. che raduna i più grandi successi della band ottenuti sia con la Warner Bros che con la I.R.S. Records, la casa discografica che aveva prodotto Michael Stipe e i suoi fino al 1987.
Il disco Out Of Time non è permeato per intero dalla malinconia che Losing my religion o Low potrebbero suggerire, prova ne siano canzoni dai toni più vivaci, come Radio Song o Shiny Happy People.

Beyond the lyrics
La prima voce a sentirsi non è quella di Micheal Stipe ma appartiene al mandolino di Peter Buck, il chitarrista che compose Losing my religion mentre guardava la tv tentando di imparare a suonare lo strumento appena acquistato. Da quelle prove venne fuori – e del tutto casualmente – uno dei riff più famosi al mondo.

La vita è più grande di te. Un’apertura che è un ceffone in piena faccia. Da un lato è interpretabile in modo soggettivo: l’immensità della vita coinvolge in prima persona chi parla, creando attorno a lui uno spazio che prima aveva destinato a un sentimento che ora inizia a morire. D’altra parte si riferisce all’oggetto di questo amore marcio, diventato ingombrante e asfissiante. Ma fine della trasmissione: la vita è più grande di te. Bisogna alzare la testa, ampliare lo sguardo. Porre fine a una grave miopia emotiva.
E tu non sei me. C’è chi ha letto dietro a questa frase e a questa canzone un desiderio di distacco dall’accanimento dei fan (cosa che avrebbero fatto poco dopo anche Eminem con Stan e i Good Charlotte con I just wanna live), il che potrebbe ben abbinarsi anche al that’s me in the spotlight (ci sono io sotto il riflettore) della strofa successiva.
Sul fronte amoroso e tu non sei me rimarca la distanza tra i due amanti: non sei me, non ami al mio stesso modo. Non ami affatto.

Uno spazio vuoto
Quello della distanza è il grande tema che Losing my religion affronta con pennellate di diversa intensità: i termini lengths e distance misurano una lontananza che è in primo luogo mentale. L’empatia è il viaggio che bisogna compiere per arrivare all’altro anche quando questi rimane fisso dov’è senza venirci incontro. C’è da riempire ad ampie falcate uno spazio vuoto. Ma ne varrà la pena?
L’incertezza tra il dire e il non dire (Oh no I’ve said too much), il timore di non aver detto abbastanza (I haven’t said enough) nascono dalla distanza che è anche mancanza di comunicazione: quando al mercato delle parole la merce è rara essa acquisisce un valore diverso. Non c’è un dialogo fluido, quindi parlare significa esporsi, ed esporsi comporta il rischio dell’errore. È un valzer relazionale sgraziato e improvvisato, nel quale si è sempre inopportuni perché dall’altra parte non c’è nessuno che ci guardi con occhio indulgente. E man mano che si danza si perde voglia (and I don’t know if I can do it), vigore, fiducia, pazienza: losing the religion.

La disillusione come risveglio

Pensavo di averti sentito: le sensazioni – è ormai chiaro – appartengono al campo dell’ignoto. Non solo non più ho certezza di quello che provo, ma ho anche il dubbio di quello che abbia provato tu. Ero convinto che avessi riso, cantato, tentato, dove tentare consiste nel percorrere quella lontananza emotiva, venirsi incontro.
Ma la consapevolezza è sempre maggiore: il sentimento e il suo oggetto sono dormienti, bisogna vegliarli, ma anche questo rasenta l’idiozia, perché è ancora una volta amare il doppio, ferirsi inutilmente. È un atto di cecità, l’ennesimo gesto eccessivo (I’ve said too much, I set it up).

Le considerazioni finali sono rivolte più a se stesso che a un immaginario amoroso uditore. Si parla di un errore: essersi compromessi e aver amato invano. E se queste fantasie si dimenassero?, se questi pensieri agitandosi in me venissero fuori ancor più brutalmente? Ecco la censura definitiva che tappa la bocca e il cuore: ora ho detto troppo.
Era solo un sogno: ecco la morale di tutto. Pensavo di averti visto partecipare alla nostra relazione ma era una canzone che cantavo da solo. Nessuna eco, nessun riverbero, non c’è partecipazione. Prova, piangi, vola, prova: è quello che deve fare lui per riprendersi e lei per amare davvero qualcuno di un amore nuovo, vero. Questo, del resto, era solo un sogno. Il prodotto di una notturna fase R.E.M.
Il video
Vincitore del Grammy per il miglior short film e di sei MTV Music Awards, quello di Losing my religion è un cortometraggio che associa ai tempi musicali flash evocativi del testo. La regia è di un giovane Tarsem Singh agli inizi della carriera; Singh osserva Michael Stipe ballare e gli ampi movimenti delle sue braccia gli fanno venire in mente il racconto Un signore molto vecchio con certe ali enormi di Gabriel García Márquez nel quale uno strano angelo invade per caso la vita di una famiglia. Nasce così il paio d’ali che Michael Stipe indossa in vari fotogrammi.
L’atmosfera scura e fortemente contrastata ricorda Caravaggio, mentre le immagini dai colori saturi s’ispirano alla fotografia indianeggiante dei francesi Pierre et Gilles. Salta subito all’occhio un moderno San Sebastiano che compare proprio quando viene pronunciato il titolo della canzone: martire per la fede, San Sebastiano è legato e trafitto. L’allegoria perfetta dell’intero brano, in cui la fede, la fiducia, è all’origine di una lacerazione interiore.
Ma, purtroppo o per fortuna, that was just a dream, just a dream.
(Immagine di copertina tratta dal video ufficiale di Losing my religion dei R.E.M.)