Mi chiamo Mattia e credo nella ricerca

«Margaret Mead disse che aiutare qualcun altro nelle difficoltà è il punto in cui la civiltà inizia» (Ira Byock)
Mi chiamo Mattia, ho ventidue anni e credo nella ricerca.
L’altro giorno ho dato biochimica applicata, una materia che spiega per filo e per segno i retroscena della sperimentazione in ambito biotecnologico. Credo di essermi innamorato. Inizio a pensare che non sia un vano ottimismo, ma una realtà concreta: l’unica possibilità che abbiamo come società di evolverci e, sì, risolverci, è quella che fonde il progresso, la curiosità e la cura verso l’altro. Senza di essi siamo nulla.
L’antropologa Margaret Mead rispose a un suo studente che il primo segno di civiltà è stato la guarigione di un femore rotto, perché significa che qualcuno l’ha fasciato e curato evitando che quell’impedimento rendesse il corpo ferito una facile preda. Per riparare un femore, per elevare il grado di civiltà del contesto in cui viviamo, servono studio e passione. Non vorrei sembrare egocentrico, ma suppongo di essere capace di entrambe le cose.

Mi chiamo Mattia, ho ventitré anni e credo nella ricerca.
Sono entrato in tesi giusto ieri. Il laboratorio è una stazione aerospaziale immensa, attrezzata e all’avanguardia. Ho dovuto trattenere un grido d’emozione! Sembra che finalmente i miei studi inizino a prendere forma e direzione, che la teoria si trasformi in pratica. Questo, stranamente, non riduce la magia ma la moltiplica.
Sto prendendo parte a uno studio in vitro sul morbo di Parkinson: simuliamo le condizioni della malattia e osserviamo come la coltura cellulare risponde a fattori esterni e ad alcune sostanze potenzialmente terapeutiche sviluppate da un altro laboratorio universitario. Lavorare in team è entusiasmante. Faccio un po’ tardi la sera, ma sono felice.

Sempre io, Mattia. Ci credo, nella ricerca, ma lei crederà mai in me?
Il congelatore in cui conserviamo le cellule si è rotto nella notte, vanificando il lavoro di tre mesi. Il mio relatore, nella rabbia, ha dato un calcio all’armadietto a fianco, così adesso siamo anche senza vetreria. Fortuna che avevo camice e guanti e non è successo niente. Qui il clima è da guerra fredda, non capisco se è anche colpa mia, avrò sbagliato qualcosa?
Il prof non mi rivolge quasi più la parola, e tutto il gruppo si muove lentamente e dopo lunga meditazione, come su una scacchiera, quasi temesse di far danno. L’altro giorno sono tornato a casa alle dieci e mezza, e dovevo ancora caricare i dati spettrofotometrici sul drive di laboratorio. Ho litigato con Marta, dice che sono un fissato, che non so prendermi il tempo per me. Che lo sto togliendo pure alla nostra relazione. Non ho neanche un momento per pensare, figuriamoci per soffrire.

Qui Mattia. Io e Marta non stiamo più insieme, e mi duole dirlo ma mi sento sollevato.
Non avrei sopportato ancora la pressione di un rapporto così intenso, oserei dire asfissiante. Le cose in laboratorio vanno a gonfie vele: i primi risultati sono esaltanti, stiamo riuscendo a comprendere alcuni meccanismi cellulari finora inspiegati. Il prof dice che probabilmente ci scappa una bella pubblicazione. M’ha persino fatto l’occhiolino, prima di andar via.
Esce sempre presto da qui, pare non si occupi di niente: così sospira il dottorando guardando il vuoto. Se gli chiedo più dettagli si chiude nel suo silenzio dopo aver detto che l’università è un grande ente di ricerca e che dovremmo essere felici di contribuirvi. Credo che parli più a se stesso che a me.

Mi chiamo Mattia, ho ventisei anni e faccio il dottorato.
In un altro ateneo, però, perché il mio è off-limits. Da quando il mio relatore è stato indagato per la scomparsa di certi fondi europei mi è sembrato inopportuno restare. Il giorno in cui mi sono laureato Marta m’ha chiesto se fossi felice. E tu? – le ho risposto. Lei sì, lei sta bene, ma stavamo parlando di me, come sto io?
Come un fuorisede che mangia pasti scongelati. Ieri ho cercato su Pubmed e visto che la pubblicazione scientifica sul mio lavoro non porta il mio nome. Il tutor aziendale del dottorato m’ha sorriso: purtroppo è la prassi. È prassi anche simulare un docile clima domestico davanti agli ispettori per poi sgridare a gran voce i tuoi dipendenti nei giorni qualunque? Chiedo per un amico.

Mi chiamo Mattia, ho trentadue anni, una laurea e un dottorato condotto in due Paesi, un’università e un ente di ricerca preclinica.
Ho investito i guadagni degli ultimi anni in un master di secondo livello e un certificato d’inglese, ma la mia casella di posta è piena solo di offerte di lavoro come commesso. Da quando mio padre si è ammalato non posso più puntare sull’estero, e qui pare che il mio aiuto non serva.
Mi fa sorridere che tra le tante malattie che potessero venirgli il fato abbia scelto giusto il morbo di Parkinson. Mia madre a volte mi guarda con un paio d’occhi, come a dirmi Guariscilo tu, con tutte le cose che sai. Ma io so un mucchio di nuvole, mamma, e il mondo è una roccia così dura.

Mi chiamo Mattia, ho trentacinque anni. Faccio l’insegnante di scienze in un liceo scientifico. Certe cose che i miei alunni dicono, certi modi che hanno di esprimersi, mi fanno sentire vecchio.
L’altro giorno ho ritrovato un appunto con la citazione di Margaret Mead sul primo segno di civiltà. È stata la prima volta che ho pianto da quando è morto mio padre. Marta si è sposata con uno che non mi somiglia per niente, meglio così.
C’è un ragazzo di quarta C che ha tutti dieci e lode, mia materia inclusa. Mi ferma sempre dopo lezione per fare qualche approfondimento, non sia mai prendesse dieci meno. Odio i secchioni, mi ricordano me. Dannazione, sto diventando come il mio relatore: un uomo ombroso che prende a calci gli armadi per far sfogare i suoi demoni. Il ragazzo vuole fare il ricercatore, me l’ha confessato l’altro giorno come fosse un gran segreto. Credo di averlo capito persino prima di lui. Che diritto ho, io, di farlo scendere da questa giostra?
«Mi sembra un’ottima idea, Michele».
Così la giostra girerà con anche lui a bordo, finché non diventerà la ruota che lo schiaccerà. S’inizia sempre con un ampio sorriso: Mi chiamo Michele e credo nella ricerca.
(Immagine di copertina: photo by National Cancer Institute on Unsplash)
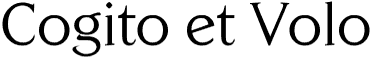






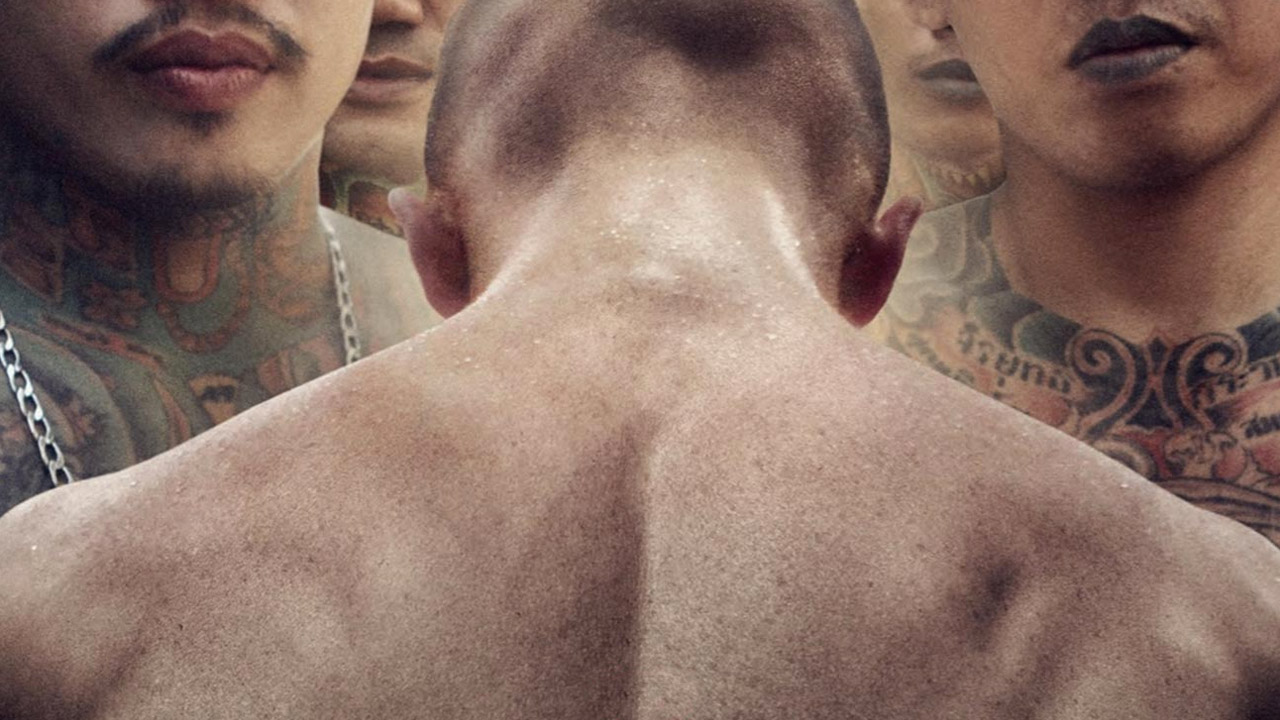




Caro Mattia,
mi chiamo Adriano e anche io credo nella ricerca, anche se la ricerca spesso non si cura del fatto che qualcuno possa davvero credere in lei.
Ti suggerisco la lettura di “L’arte della scienza”: https://www.earth-prints.org/bitstream/2122/15707/1/L%27arte%20della%20scienza%20%28Nardi%2c%202022%29.pdf
Per i tuoi studenti ti consiglio invece “La scienza e la follia”: https://www.earth-prints.org/bitstream/2122/14811/6/La%20scienza%20e%20la%20follia%20%28Nardi%2c%20ott2021%29.pdf
Due brevi letture che descrivono la malattia e la cura per chi crede nella ricerca.
Per aspera ad astra!